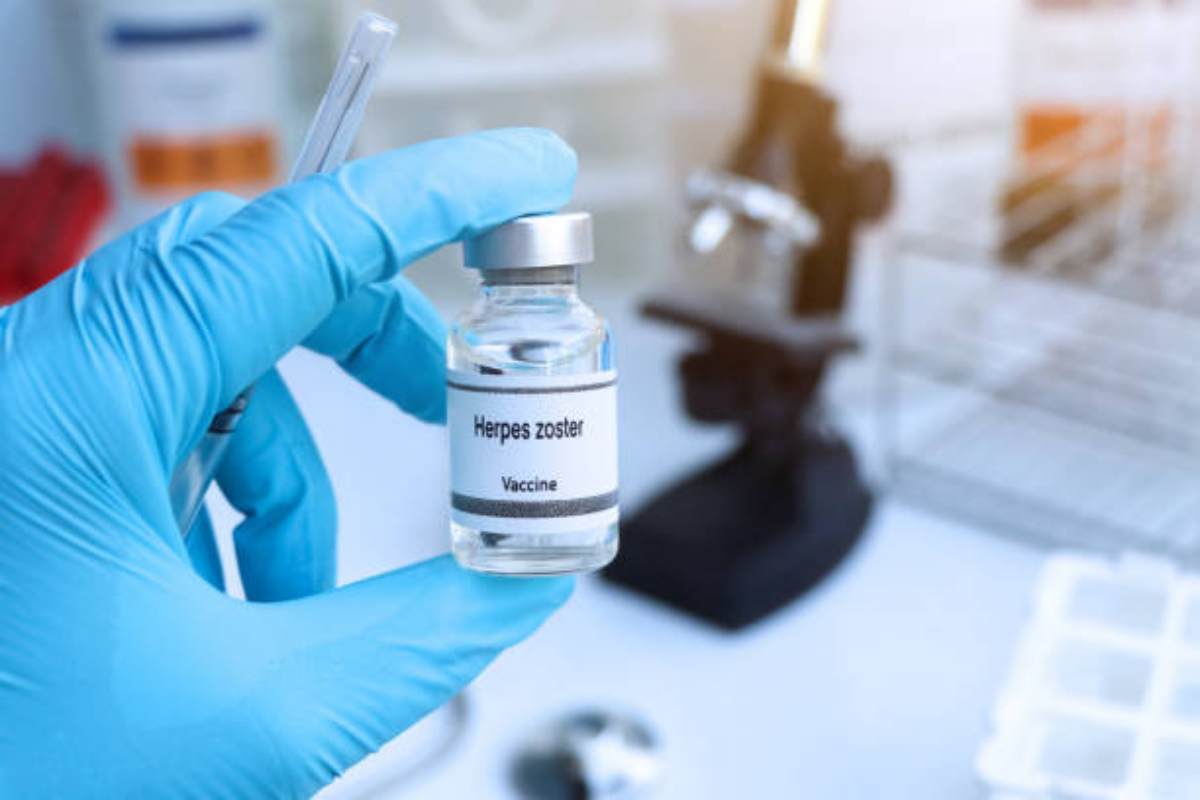Nuovi farmaci per i tumori: l’Ema e la Fda differiscono nelle autorizzazioni. Mentre l’agenzia americana è più permissiva, l’Ema si concentra su sicurezza ed efficacia
La questione dell’approvazione dei nuovi farmaci per il trattamento dei tumori è un tema di grande rilevanza e complessità, specialmente quando si confrontano le decisioni dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) e della Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti. Un recente studio pubblicato su Lancet Oncology dai ricercatori dell’Università di Torino ha rivelato che, su circa 162 indicazioni terapeutiche analizzate, le due agenzie hanno approvato farmaci per pazienti con caratteristiche molto diverse in oltre la metà dei casi. Questo solleva interrogativi fondamentali sul motivo per cui due delle più importanti autorità sanitarie mondiali adottino approcci così diversi e quali siano le implicazioni per i pazienti affetti da cancro.
Differenze nelle approvazioni
Le differenze tra Ema e Fda non sono solo di natura burocratica, ma riflettono due filosofie contrastanti nella valutazione dei farmaci. La Fda tende a concedere autorizzazioni più ampie, favorendo un accesso più rapido ai nuovi trattamenti, ma questo approccio comporta anche un rischio maggiore per i pazienti, che potrebbero ricevere terapie la cui efficacia e sicurezza non sono state completamente stabilite. Al contrario, l’Ema adotta un approccio più cauto, allungando i tempi di approvazione ma garantendo una maggiore certezza in merito all’efficacia e alla tossicità dei farmaci approvati.
Gianluca Miglio, professore di farmacologia all’Università di Torino, ha evidenziato come le differenze nelle approvazioni possano portare a situazioni in cui pazienti con lo stesso tipo di cancro si trovano a non avere accesso agli stessi trattamenti a causa della loro posizione geografica. Questo solleva un importante tema di disuguaglianza nell’accesso alle cure: in molti casi, il destino di un paziente può dipendere non solo dalla malattia, ma anche dal paese in cui vive.
Disuguaglianze nell’accesso alle terapie
Le disparità nell’accesso alle terapie oncologiche sono un problema globalmente riconosciuto. Non solo esistono differenze marcate tra paesi a basso e medio reddito e quelli occidentali, ma anche all’interno delle nazioni stesse, le disuguaglianze sono sempre più evidenti. In Italia, ad esempio, il fenomeno della “tossicità finanziaria” colpisce circa il 26% dei pazienti oncologici, evidenziando come le spese per cure e trattamenti possano gravare pesantemente sulle famiglie, specialmente in un contesto in cui l’accesso alle terapie innovative non è garantito per tutti.
Lo studio condotto dai ricercatori torinesi ha analizzato 162 indicazioni terapeutiche di 80 farmaci per tumori solidi e tumori del sangue approvati da Ema tra gennaio 2015 e settembre 2022, confrontandole con le indicazioni approvate dalla Fda. Le discrepanze identificate riguardano aspetti cruciali quali la collocazione nella terapia, i requisiti di eleggibilità dei biomarcatori e le caratteristiche dei pazienti. Queste differenze possono creare confusione e frustrazione tra i pazienti e i medici, che si trovano a dover navigare un panorama complesso e variabile.
Rischi e opportunità
La questione dell’indicazione dei medicinali è centrale nel dibattito tra Ema e Fda. Come evidenziato da Armando Genazzani, docente di Scienza e Tecnologia del Farmaco, le agenzie regolatorie devono decidere quali pazienti possono assumere un medicinale, bilanciando i benefici e i rischi. Mentre la Fda potrebbe essere più propensa a estendere l’uso di un farmaco a pazienti non direttamente inclusi nei trial clinici, l’Ema si concentra su un approccio più conservativo, riservando i medicinali a coloro per i quali ci sono prove più solide della loro efficacia.
Questa differenza di approccio ha implicazioni significative: da un lato, i pazienti americani possono avere accesso a un numero maggiore di farmaci, ma con una maggiore incidenza di ritiri dal mercato quando emergono dati negativi sulla loro efficacia o sicurezza. Dall’altro, i pazienti europei possono godere di una maggiore certezza riguardo ai farmaci che assumono, ma potrebbero affrontare ritardi nell’accesso alle nuove terapie.
La situazione in Italia
In Italia, la questione dell’approvazione e disponibilità dei farmaci oncologici è particolarmente rilevante. Massimo Di Maio, presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), ha sottolineato che l’Italia è fortunata perché, nella maggior parte dei casi, i farmaci approvati sono disponibili gratuitamente grazie al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, permangono sfide significative, come il lungo processo burocratico che può ritardare l’accesso ai trattamenti. La presenza di Prontuari Terapeutici, che limitano l’accesso ai farmaci in base a criteri regionali, rappresenta un ostacolo che potrebbe essere superato per garantire un accesso equo e tempestivo a tutte le cure necessarie.
In un contesto in cui i pazienti con tumori in stadio avanzato hanno bisogno di accesso rapido a nuove terapie per migliorare la loro qualità di vita e le loro prospettive, la questione dell’approvazione e dell’accessibilità dei farmaci rimane uno dei temi più urgenti e complessi da affrontare. La ricerca continua e il dialogo tra le agenzie regolatorie, i medici e i pazienti saranno cruciali per navigare queste sfide e garantire che tutti i malati di cancro possano beneficiare delle migliori opzioni terapeutiche disponibili.